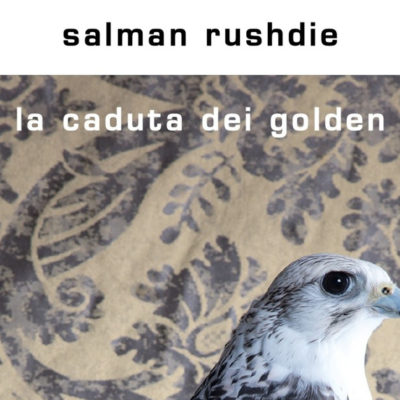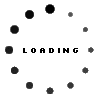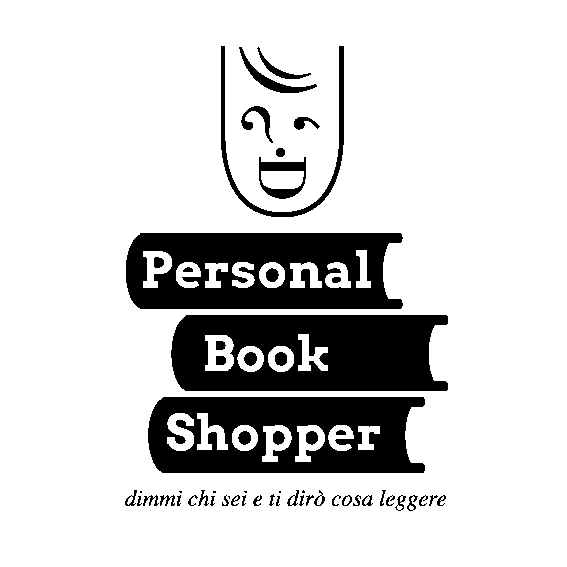Blog
Puristi, rassegnatevi! Le lingue cambiano
24 settembre 2013
Articolo di Valentina apparso su “il Bo” il 24 settembre 2013.
Puristi della lingua: rassegnatevi. Che l’italiano stia cambiando è un fatto naturale, caratteristico di qualsiasi linguaggio, perché una lingua è un oggetto estremamente fluido e rinasce ad ogni frase pronunciata da un parlante. Lo assicurano i linguisti, che non sono, come si sarebbe portati a credere, i numi tutelari del Verbo, ma degli attenti osservatori dei fenomeni che intervengono nell’uso della lingua e, come tali, si limitano a constatare e ad analizzare le ragioni del cambiamento: non spetta a loro il compito di cristallizzare le lingue in una forma stabilita. Andrea De Benedetti, nel suo saggio Val più la pratica, ci tiene a precisarlo: il linguista non è “l’avvocato” della lingua, semmai il suo “notaio”.
Non si scandalizzano quindi, i linguisti, se aumentano nell’italiano gli anglicismi, o se il web ci spinge a “evitare le lettere accentate che possano creare problemi al ricevente”.
Chi si scandalizza dunque? Steven Pinker, docente di psicologia cognitiva ad Harvard ed ex allievo di Noam Chomsky, identifica ne L’istinto del linguaggio ben quattro tipologie di “difensori del linguaggio”: dal “word-watcher”, ricercatore in qualche altro campo che asseconda una sua passione morbosa, al “Geremia”, che profetizza futuri apocalittici del tipo “non sapremo più parlare”, passando per “l’intrattenitore”, appassionato di giochi di parole, fino al “saggio”, forse il più competente, non certo un linguista di professione, ma sicuramente un riconosciuto cultore del linguaggio. De Benedetti li battezza ironicamente tutti “neo- crusc” (adepti, cioè, di un’Accademia della Crusca che ha ricominciato a fare il suo mestiere di salvaguardia della lingua italiana), ma sembra avercela in modo particolare con chi si ostina a voler insegnare delle regole prescrittive sull’utilizzo dell’italiano (maestri e professori?).
Non si tratta solo di accettare il cambiamento portato dalla storia e dalla geopolitica, come il prestito linguistico (che c’è da sempre: basta pensare a quanti termini di origine francese sono diventati correnti in italiano fra l’illuminismo e Napoleone). La vera questione, secondo l’autore, è infatti la capacità di pensare le lingue come organismi vivi e di superare dei tabù congeniti in chi si ritiene un buon parlante del proprio idioma, compresi quegli inglesi la cui storia del linguaggio è millenaria e che all’apparenza la fanno da padroni nell’infestare le lingue altrui.
Se a qualcuno di noi viene infatti la pelle d’oca in presenza del “che” polivalente o quando gli viene detto (a loro!) che non dovrebbero giudicare come ciascuno parla perché è personale, ricordiamoci che gli inglesi si sentono dare dei feticisti del whom, quando insistono per usarlo correttamente come pronome relativo oggetto e non ammettono al suo posto l’uso del pronome relativo soggetto who (ma ai tempi di Shakespeare si usava ye per il soggetto ed you per l’oggetto, che oggi è diventato forma unica e nessuno rimpiange il caduto).
La spiegazione dell’inarrestabilità del cambiamento la dà il linguista: quando la lingua dispone di due forme concorrenti per una stessa funzione, tende a prevalere quella più duttile come, spiega De Benedetti, quando si ha in casa “un robot da cucina che trita impasta e centrifuga qualsiasi ingrediente e uno che serve solo a passare le patate: alla fine si userà sempre il primo e si dimenticherà il secondo in fondo all’armadietto”. Ecco perché si usa sempre di più gli al posto di le o loro (“digli” per “dille” o “di’ loro”), che al posto di cui, in cui, di cui, dove: lo ha fatto persino Pascoli (“E s’aprono i fiori notturni/ nell’ora che penso ai miei cari) a cui è seguito Jovanotti: “Sono un ragazzo fortunato perché non c’è niente che ho bisogno”. È una sorta di rasoio di Occam, quindi, quello che sta livellando la nostra lingua: con lo stesso criterio, infatti, si potrebbe scrivere qual è con l’apostrofo (per analogia con dov’è, cos’è, quand’è) o di togliere la i dal plurale di camicia, tanto non viene pronunciata e dimenticarsi sottigliezze come la d eufonica.
D’altronde, fu Manzoni a introdurre anche nello scritto lui per egli: scandalo oggi del tutto rientrato. E quando una forma particolare ha la sua ragione d’essere, rimane: a partire dal congiuntivo, eterno indiziato di scomparsa. La riprova? Su internet, dove le subordinate (credo che sia, penso che sia) vedono il congiuntivo prevalere sull’indicativo (credo che è) nella stragrande maggioranza delle occorrenze. E non per caso: possibilità e fatto sono cose diverse e la lingua continua a indicarle diversamente.
Diego Pescarini, ricercatore al dipartimento di studi linguistici e letterari dell’università di Padova, rassicura e al contempo lascia senza certezze chi teme il famigerato “impoverimento del linguaggio”: qualsiasi lingua, spiega, è sempre andata incontro a fasi evolutive e l’impoverimento è tale a seconda del lato da cui si si guarda la storia. Spesso le modifiche sono legate al contesto (le competenze lessicali dei dialetti, per esempio, si riducono perché sta sparendo il mondo rurale cui il lessico dialettale è legato), o alle mode, ma talvolta fenomeni che sembravano inarrestabili sono regrediti fino a scomparire.
Una questione di evoluzione storica, quindi. Philippe Daverio, l’esperto d’arte (in realtà dice di sé “sono un semiologo”) in una recente conferenza al Centro culturale San Gaetano di Padova ha parlato quasi esclusivamente di linguistica perché, spiega, si conosce un popolo e la sua cultura solo quando se ne padroneggia la lingua (Federico II di Prussia diceva: “Parlo il francese con le dame, l’inglese coi mercanti, lo spagnolo con dio, il tedesco con i miei cavalli e l’italiano con gli angeli”). Ha poi dato, in chiusura, la sua personale definizione di “modernità” e di “contemporaneità”. È moderno, per Daverio, chi pensa che il passato ci appartenga (come Winckelmann che nel 1764 andò a Paestum per odorare la celebre rosa e ritrovare nel presente un frammento di antichità) ed è invece contemporaneo chi, in ogni epoca, è disposto ad accettare il cambiamento radicale.
Ecco dunque: i linguisti sono forse gli effettivi contemporanei, e tra gli uomini della strada, invece, ci sono ancora molti fermi alla modernità. Lasciamo loro queste sorpassate idiosincrasie linguistiche.
Valentina Berengo