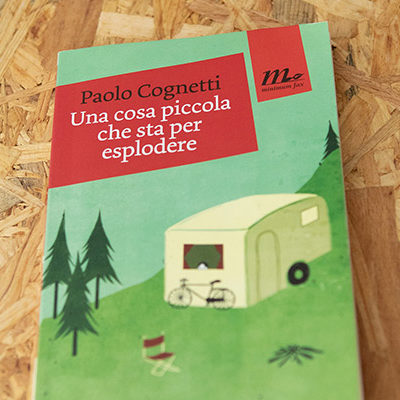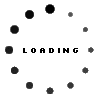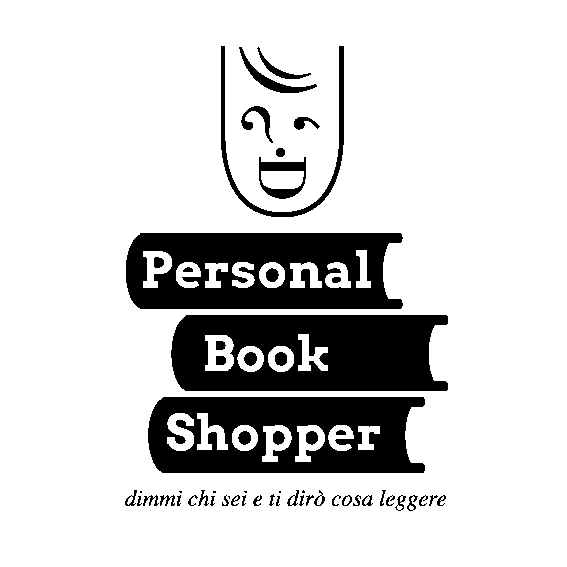Blog
Camon: quando la letteratura è un rito di salvezza
31 ottobre 2013
Articolo di Valentina apparso su “il Bo” il 31 ottobre 2013 sull’opera dello scrittore Ferdinando Camon.
Secondo le definizioni della statica, un corpo passa dalla condizione di equilibrio stabile a quella di equilibrio instabile quando le forze che agiscono su di esso raggiungono un dato valore critico; a quel punto una minima perturbazione può far collassare la struttura: in questa condizione l’energia potenziale raggiunge un massimo.
Una descrizione del genere, seppur tecnica, si presta perfettamente a inquadrare l’opera letteraria di Ferdinando Camon, autore noto principalmente per il suo “ciclo degli ultimi”, ossia un quartetto di romanzi, che vivono di vita propria, in cui – nessuno escluso – si rispecchia la fine di un universo, quello della civiltà contadina, celebrato dall’elegia nostalgica di uno dei suoi figli (Camon nasce nella campagna veneta, nei pressi di Montagnana). Il mondo di cui si fa cantore, infatti, è una società che ha raggiunto, e superato, quell’instabilità che scivola verso il collasso e l’autore nel coglierla la vuole celebrare, perché ne percepisce istintivamente il massimo potenziale, quello della morte che si trasforma in vita nuova. Ed è proprio l’ineludibilità di ogni crisi, la precarietà inguaribile di un qualsivoglia universo culturale e sociale, che ha permesso all’autore di penetrarla così profondamente.
In un recente incontro a Padova, racconta infatti l’angoscia – la sua – provata nello scoprire che la civiltà in cui era stato allevato non lo avrebbe accompagnato per tutta la vita; l’horror vacui nei confronti del futuro che si fa presente in forme insospettate (“pensavo che mio figlio sarebbe stato con me come io sono stato con mio padre: mi sbagliavo”, “le mie nipoti non parlano neppure l’italiano”) e dà il nome di lutto a questa angoscia. La crisi la definisce perdita di regole morali e comportamentali, da cui lo smarrimento, che non è figlio dell’economia, ma di un sistema che muta drasticamente. Che addio si dà, chiede, quando muore una famiglia, una casa, quando muore un dio?
Un corpo che ha perso la sua condizione di equilibrio può instaurarne un’altra, attorno a un nuovo baricentro. Questo accade in fisica, e forse anche tra gli uomini, ma tra essi, perché ciò avvenga, c’è bisogno di compiere un rito di salvezza. L’autore dice di essersene reso conto quando, tra i diversi libri che gli arrivavano nella cassetta delle lettere per essere recensiti (oltre che narratore è anche giornalista), trovò Il simbolismo della messa di Jung. Lui, freudiano convinto (per anni fece sedute di psicanalisi con Cesare Musatti), ha trovato proprio nell’inconscio collettivo la risposta al successo di Un altare per la madre, con cui Camon ha vinto il Premio Strega nel 1978. Il romanzo, che descrive la lotta dell’autore per affrontare la morte della madre, racconta il superamento di un universo individuale, per farsi voce collettiva. L’autore, minimizzando sul premio (“avevano bisogno di riverginare l’attribuzione delle vittorie”), racconta una serie di aneddoti che gli hanno rivelato la doppia natura di quest’opera e il compiersi del rito di salvezza descritto proprio da Jung. Il traduttore della Gallimard gli chiese infatti di poter dedicare l’edizione francese a Roland Barthes da poco scomparso, così la traduttrice polacca lo volle in dedica alla figlia per la stessa ragione; ricevette persino una lettera da un ebreo americano che gli confessò di “aver letto a un funerale tre pagine del suo memoriale”.
Ma non è solo con l’Altare che le vicende autobiografiche si trasfigurano in monito corale. Accade in quasi ogni opera di Camon, anche quando ciò resta incompreso o viene travisato.
I suoi compaesani di origine, infatti, non l’hanno mai perdonato per aver “tradito” (se ne andò per non tornare) e per aver svelato la loro verità (si sfiorò persino il procedimento legale ma il tutto finì con un pranzo di riconciliazione in cui i contadini, con gran disappunto dell’autore, gli fecero intonare da un tenore “la rondine al nido”). Sono i giudici del processo per la strage di Bologna a scorgere, nelle 11 pagine di Occidente. Il diritto di strage trovate ricopiate nel quaderno di un terrorista, l’aggancio per la ricostruzione del folle e segreto movente intellettuale del crimine. Con La malattia chiamata uomo, Camon invece universalizza la sofferenza umana e il suo processo catartico attraverso l’analisi. Si consuma così il tradimento definitivo: la rivelazione dell’irrivelabile, cioè di quel che avviene tra le mura della stanza dove si tiene una seduta di psicanalisi.
Eppure, spiega Cesare De Michelis, letterato ed editore, il talento di Camon “sta proprio nel riuscire a registrare, di un processo collettivo che volge al suo termine, l’istante in cui la morte si compie, in cui l’equilibrio instabile diviene collasso, attraverso il racconto dell’esperienza personale”. Non è puro memorialismo il suo, piuttosto si intravvedono i contorni del racconto mitico dove l’uno è in realtà l’archetipo dei molti. E quando si consegna attraverso la scrittura un’esperienza del passato al futuro, essa diventa uno strumento di sopravvivenza in grado di alleviare la sofferenza facendola sentire meno irreparabile, nel momento stesso in cui la ferma sulla carta. Si potrebbe persino definire funzione morale, quella della sua letteratura: perché combattere la morte che ogni giorno si compie cercando di tenere insieme passato e futuro nel presente della scrittura, è davvero un rito di salvezza.
Valentina Berengo