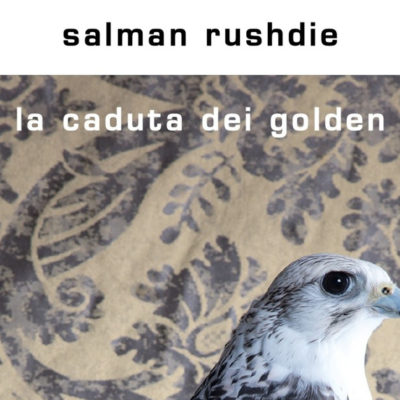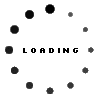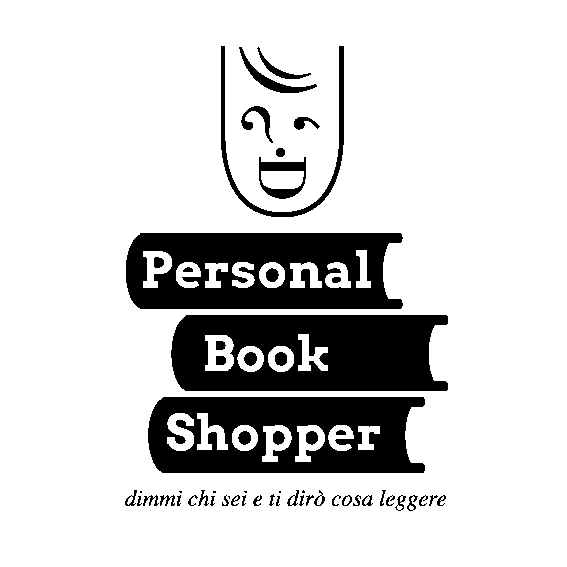Blog
“La morte corre sul fiume” e la musica l’accompagna
9 aprile 2016
di Luca Leone
Quanto compreso tra pagina 228 e pagina 229 di “The night of The Hunter” di Davis Grubb, uscito in Italia come “La morte corre sul fiume”, potrebbe essere uno dei più promettenti candidati alla vittoria, nella categoria “ogni epoca”, di un ipotetico premio letterario rivolto ai singoli paragrafi dei libri. L’utilizzo della musica, nel computo complessivo dei motivi di grandezza di queste poche righe, è certamente da non sottovalutare.
Si narra di una sorta di resa dei conti, giunta alla fine di una lunga contesa. Il terreno d’ambientazione è un piccolo podere solitario a distanza ragguardevole dal più vicino insediamento umano, da qualche parte nel West Virginia, negli anni venti.
Gli attori in scena stanno a pochi metri di distanza uno dall’altro: da una parte un’anziana signora su una sedia a dondolo, Rachel Cooper, con un fucile dalle canne molto lunghe stretto tra le mani. Dall’altra parte un uomo vestito di nero, accucciato al fianco del suo cavallo, a stretta distanza dall’uscio stesso.
In termini pragmatici non succede praticamente nulla: è un momento di pura attesa, carico di energia potenziale.
Lo stato di sospensione è portato ad un crescendo costante dalla pesante posta in gioco, dagli oggetti della contesa: John e Pearl. Quindici anni in due, sono i piccoli protagonisti del romanzo. Sin dall’inizio del libro vengono dispersi nel mondo da un destino particolarmente maligno, che con loro ha anche scelto bene di accanirsi.
Particolare non di secondaria rilevanza: è notte, la condizione ideale per ogni vero cacciatore.
Posta così, anche per chi non avesse letto il libro, non dovrebbe essere difficile indovinare chi è cacciatore di chi, chi veste i panni del buono e chi del cattivo.
Una vecchia donna con un fucile in mano e dei bambini (non suoi) chiusi in casa, non dovrebbe promettere niente di buono: tiene in ostaggio i bambini e impedisce al reverendo di salvarli.
È l’esatto contrario. Il reverendo è una macchina del terrore. Malvagio oltre ogni ordine di misura, odia praticamente tutto a parte il denaro (le donne, quelle le ammazzerebbe tutte). La toga è il costume sotto cui nasconde il suo reale carattere. Riesce a spacciarsi come buono, perché affabulatore di primo ordine, incanta con la sua voce profondissima, con cui recita, nei momenti opportuni, versetti altisonanti della Bibbia.
Sarà forse il passato da pubblicitario di Davis Grubb ad averlo aiutato nella costruzione di un personaggio impossibile da dimenticare. Le due scritte Hate e Love sulle nocche di mano destra e sinistra, sono tutt’ora uno dei messaggi più semplici e d’impatto della storia della letteratura (e del cinema, grazie al film tratto dal libro nel 1955 diretto di Charles Laughton).
La vecchia è il suo contraltare, immagine di un bene occultato sotto apparenze poco rassicuranti: è sola, scorbutica, non frequenta la messa da tempo. Fa beneficenza spassionatamente, perseguendo una missione in silenzio, senza ricompense: raccoglie e accudisce i bimbi persi che bussano alla sua porta.
Tornando nuovamente alla biografia di Grubb, è noto che la sua prima opzione di vita fosse quella di fare il pittore. Purtroppo si è dovuto arrendere alla sua “color blindness”, una malattia che impedisce agli occhi di distinguere bene i colori. La scena di cui stiamo parlando è dipinta, più che scritta, come se non avesse mai abbandonato il pennello per la penna.
È un quadro, perché è essenziale e capace di raccontare tanto senza avvalersi del movimento. Solo a tratti l’immobilismo è tradito da alcuni micro-movimenti, piccole variazioni della staticità: gli occhi della vecchia che si chiudono, incoraggiati dal sonno, le mani del predicatore che tremano di delirio maniacale e di impazienza.
Poi la sua bocca che si apre, e che con la stessa voce da affabulatore, cavernosa, che fa eco nei campi disabitati intorno, canta. Canta un inno sacro: Leaning on the Everlasting Arms.
La donna, per stemperare il terrore e per dimostrarsi alla pari col male assiepato ai suoi piedi, si unisce al suo canto. Cantano assieme nel buio: “E forse perché aveva bisogno che Dio le desse forza, ma anche per coprire quella voce, si unì all’antico canto”.
La canzone venne scritta da Anthony J. Showalter (assieme ad di Elisha Hoffman) nel lontano 1879 per consolare il lutto di due allievi della sua scuola di musica. Per il cacciatore è una sorta di rituale prima dell’offensiva. La cupezza della sua voce, carica di fermento omicida, si scontra con la bontà evangelica di quei versi. La vecchia, invece, invoca realmente le “eterne braccia di Dio”, in maniera sincera, oltremodo cristiana, sebbene si sia, da tempo, allontanata da Lui. Le voci si incontrano a metà strada, e li uniscono, precedono tutto ciò che in seguito avverrà: la caccia, resa dei conti vera e propria.
Ascolta Luca Leone che ti racconta qualcosa in più:
In copertina la locandina del film tratto dal romanzo nel 1955 per la regia di Charles Laughton.